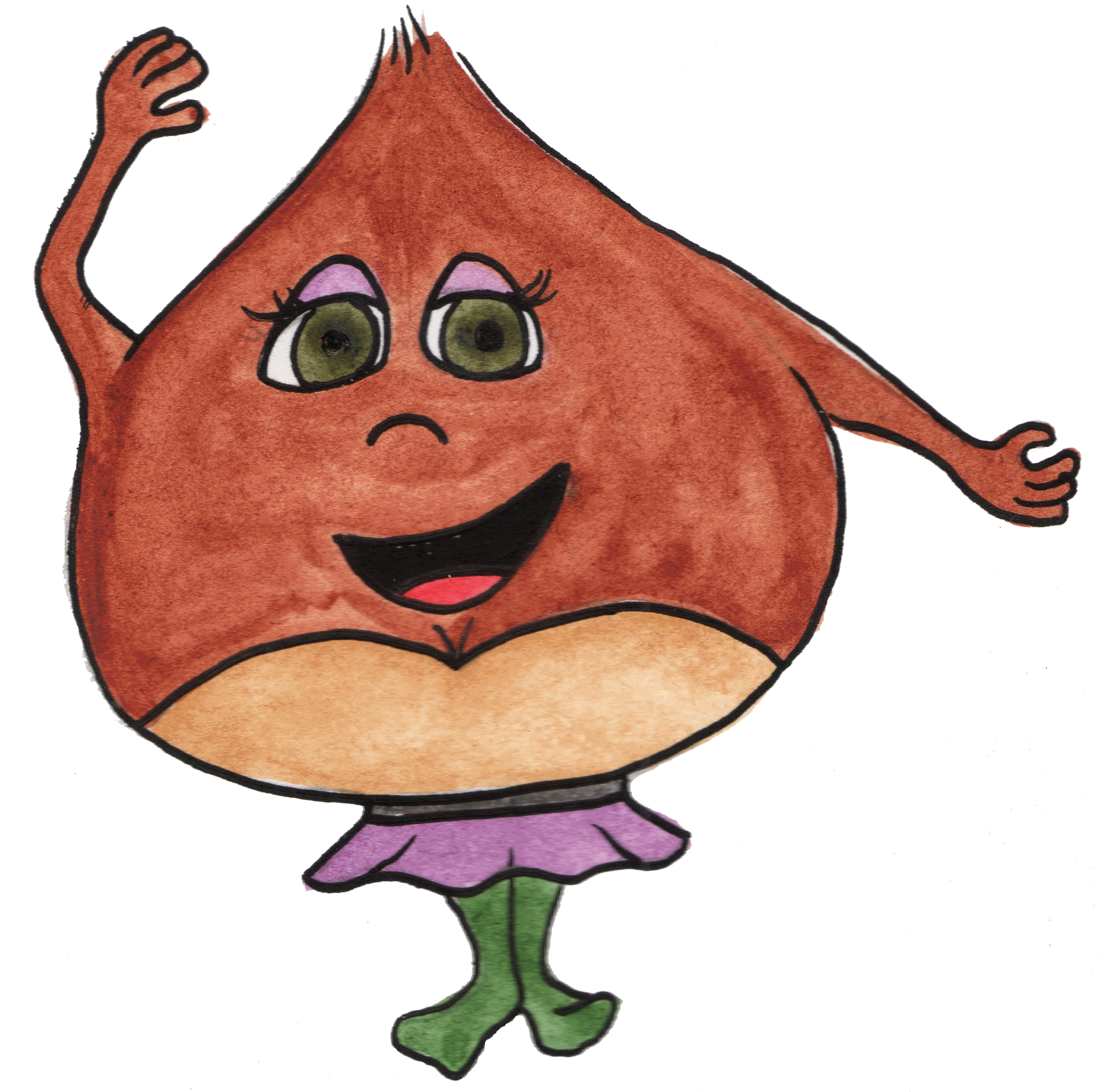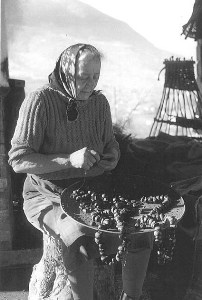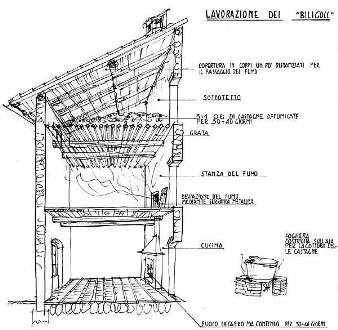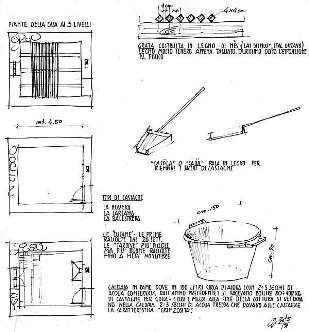|
|
|
|
BILIGOCC E...
 Sovente tecnologie avanzate e necessità mutano
costume e habitat del nostro vivere,
allontanando usi e tradizioni, obbligandoci a
faticose ricerche e a non sempre facili e
veritieri recuperi delle nostre radici. Ma fortunatamente per quanto andiamo a
descrivere (castagneti e biligocc della Valle
del Lujo) non mancano attendibili
documentazioni. Dal catasto Austriaco (1850
circa) rileviamo che se discreta era la
quantità dei “castagni da frutto” sul lato
destro del Serio e del Lujo perché integrati
con altre culture, sul lato sinistro, alle
pendici del Misma, del Pizzo, del Pranzà,
notevole si presentava la copertura boschiva
grazie anche ai terreni più freddi e umidi
ideali per tale coltivazione. L’industrializzazione ha trasformato il
territorio, migliorando sicuramente le
condizioni di vita degli abitanti, ma ha
inevitabilmente ridotto l’attività agricola
della valle, trascurando sovente la cura dei
boschi. E se delle castagne ne abbiamo perso il
consumo, vediamo di ricordarle per nomi e
specie diversificandole in careane (le più
grosse), balestrere
(di consumo più comune),
ostane, rosere, beline
e doaole. Non tutte le qualità si
prestano all’”operazione biligocc”, secondo
gli esperti le migliori sono le “ostane” e le
“careane”. Ma vediamone storia e trasformazione iniziando
da Poscante, patria dei biligocc . E’ in
questa piccola località della Valle Brembana,
nonché frazione del comune di Zogno che,
secondo alcuni appassionati di storia antica,
affonda la sue radici la secolare tradizione
orobica. Si racconta a tale proposito che nel medioevo
un contadino di “Poscantum” (Poscante) (la
denominazione appare in un atto del 1249)
volle sperimentare un procedimento per poter
gustare la fragranza di questi frutti anche
fuori stagione. Fece cuocere le castagne per
circa due ore e le lasciò essiccare all’aria
aperta per sette giorni e sette notti, così
potè riassaporare il gusto genuino delle
castagne affumicate sino al periodo pasquale. Quanto ci sia di vero in questo singolare
racconto non lo sappiamo ma è certa la prima
citazione (1490) di Giovanni Bressani, poeta
vernacolo, che scrive: Sovente tecnologie avanzate e necessità mutano
costume e habitat del nostro vivere,
allontanando usi e tradizioni, obbligandoci a
faticose ricerche e a non sempre facili e
veritieri recuperi delle nostre radici. Ma fortunatamente per quanto andiamo a
descrivere (castagneti e biligocc della Valle
del Lujo) non mancano attendibili
documentazioni. Dal catasto Austriaco (1850
circa) rileviamo che se discreta era la
quantità dei “castagni da frutto” sul lato
destro del Serio e del Lujo perché integrati
con altre culture, sul lato sinistro, alle
pendici del Misma, del Pizzo, del Pranzà,
notevole si presentava la copertura boschiva
grazie anche ai terreni più freddi e umidi
ideali per tale coltivazione. L’industrializzazione ha trasformato il
territorio, migliorando sicuramente le
condizioni di vita degli abitanti, ma ha
inevitabilmente ridotto l’attività agricola
della valle, trascurando sovente la cura dei
boschi. E se delle castagne ne abbiamo perso il
consumo, vediamo di ricordarle per nomi e
specie diversificandole in careane (le più
grosse), balestrere
(di consumo più comune),
ostane, rosere, beline
e doaole. Non tutte le qualità si
prestano all’”operazione biligocc”, secondo
gli esperti le migliori sono le “ostane” e le
“careane”. Ma vediamone storia e trasformazione iniziando
da Poscante, patria dei biligocc . E’ in
questa piccola località della Valle Brembana,
nonché frazione del comune di Zogno che,
secondo alcuni appassionati di storia antica,
affonda la sue radici la secolare tradizione
orobica. Si racconta a tale proposito che nel medioevo
un contadino di “Poscantum” (Poscante) (la
denominazione appare in un atto del 1249)
volle sperimentare un procedimento per poter
gustare la fragranza di questi frutti anche
fuori stagione. Fece cuocere le castagne per
circa due ore e le lasciò essiccare all’aria
aperta per sette giorni e sette notti, così
potè riassaporare il gusto genuino delle
castagne affumicate sino al periodo pasquale. Quanto ci sia di vero in questo singolare
racconto non lo sappiamo ma è certa la prima
citazione (1490) di Giovanni Bressani, poeta
vernacolo, che scrive:
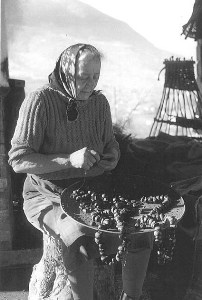
Gne con tal desideri Sant’Antoni
Per vèend biligòcc, pom e castegni pesti,
Da Poltranga a Surisel specie i doni
Gne ai desidera ch’as faghi di festi.

GUARDA ALTRI ESEMPI DI CASTAGNE
NON COMMESTIBILI CHE PUOI TROVARE IN VALLE
DEL LUJO: ippocastano
Foto delle castagne di: Eugenio Consonni
LA CASTAGNA: L’ANTICO «PANE DEI
POVERI»

Croccanti se cotte sulla graticola o farinose se bollite
in una pentola d’acqua, le castagne conservano il gusto dei sapori antichi,
delle tradizioni di una volta. Del resto, il castagno era un albero tenuto in
grandissima considerazione, perché da esso si ricavava dell’ottima legna e soprattutto le
castagne, che per diversi mesi all’anno servivano ad integrare la povera
alimentazione delle famiglie contadine. Le castagne erano considerate un vero e
proprio «pane del bosco».
Gli anziani sapevano distinguere le diverse varietà di castagne, che maturavano
in momenti differenti: c’erano le ostane o ostanèle (cioè agostana, che si
raccoglievano per prime), le balestrere (dalla caratteristica buccia rossa), le
doaole, le careane. I castagneti venivano curati come giardini, si tagliava
regolarmente l’erba e non si facevano crescere i rovi. Insomma, nella castagna
c’è un po’ di storia bergamasca, di quelle tradizioni che si vorrebbe
conservare e che oggi rivivono a fatica in poche fiere e sagre di paese. Come a
Casale di Albino, in Valle del Lujo, da secoli terra di elezione delle
castagne, dove il Gruppo Culturale «Amici di Casale» promuove da tempo il
recupero e la valorizzazione della castagna, organizzando la «Sagra delle borole»,
la «Sagra dei Biligocc», convegni e mostre tematiche sulla castagna, ma anche
istituendo l’«area protetta del castagno», per la salvaguardia di un antico
castagneto.
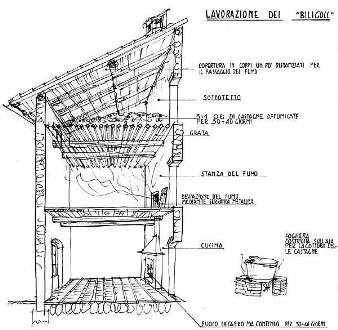
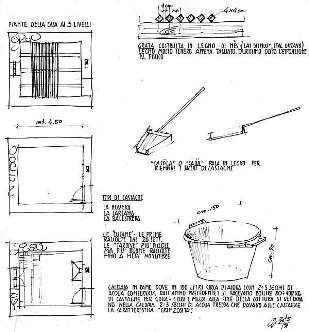
|
|